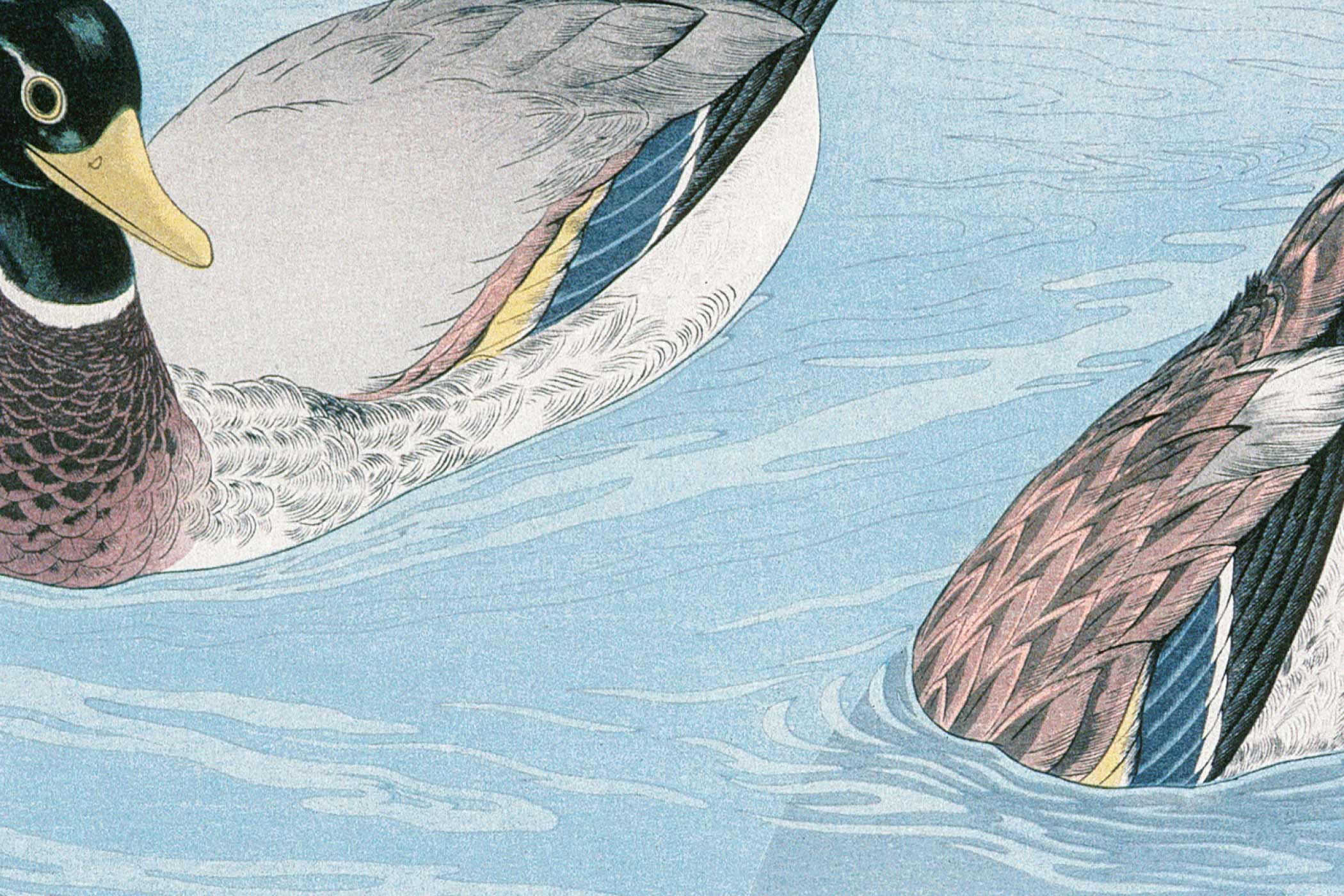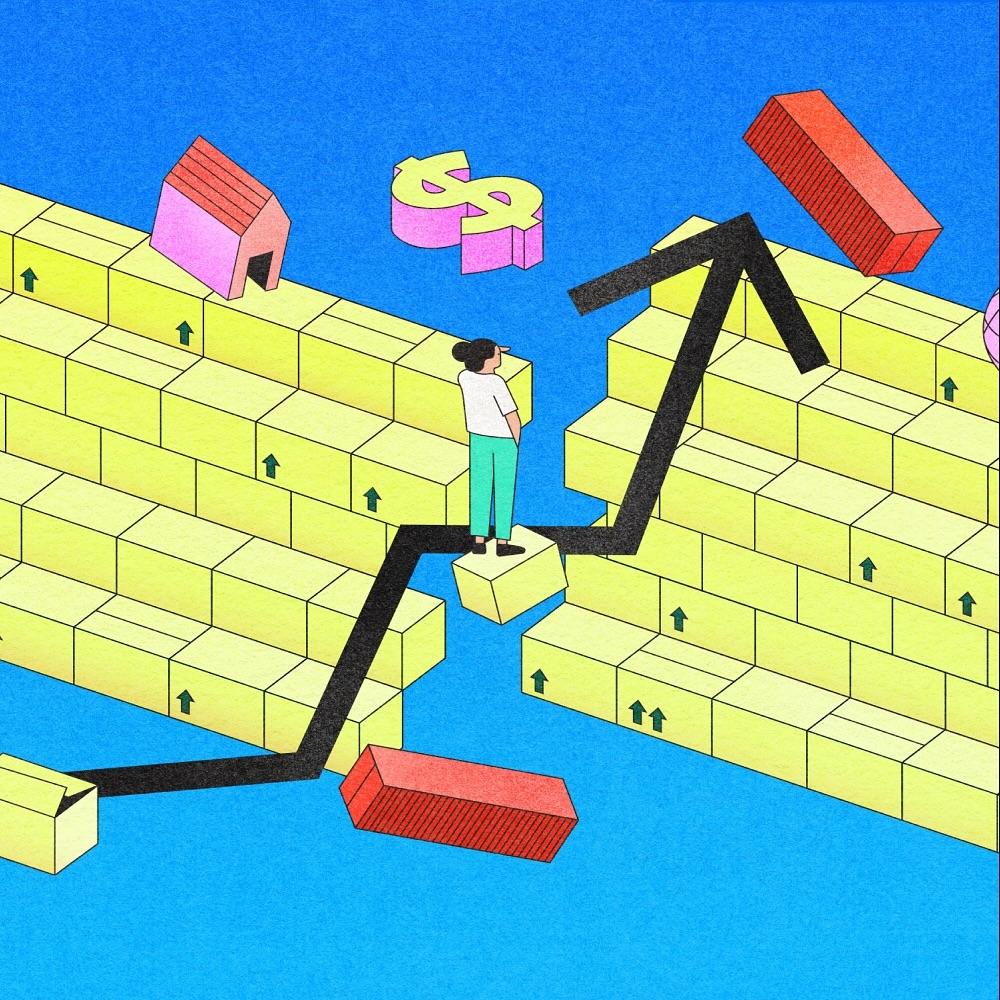Il Paradosso del Piano ReArm Europe
22.04.2025 / Andrea Passante – Viola Andreolli
Il dibattito politico italiano è attualmente dominato da un tema profondamente sfaccettato e colmo di snodi sociali, economici e, inevitabilmente, di carattere etico: il riarmo europeo. D’altronde, parlare di “prepararsi alla guerra” nel 2025 fa sicuramente un certo effetto. Il 6 marzo il Consiglio Europeo, riunito in seduta straordinaria a Bruxelles, ha approvato ufficialmente il ReArm Europe: il piano per il riarmo europeo da 800 miliardi di euro per potenziare la Difesa comune europea, annunciato il 4 marzo dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen.
Ma in cosa consiste nello specifico questo progetto? Per “aumento della difesa comune europea” si intende il potenziamento delle capacità militari e strategiche dell’Unione Europea, in una logica di deterrenza (in chiave, più o meno esplicitamente, antirussa). Sostanzialmente, i 27 Stati membri dell’UE verrebbero temporaneamente svincolati dal Patto di Stabilità – che prevede che il debito pubblico nazionale non debba superare il 3% in rapporto al PIL – ma solo per quanto riguarda gli investimenti in ambito difensivo, e fino ad un massimo di 650 miliardi di euro. A questi si aggiungerebbero altri 150 miliardi erogati sotto forma di prestiti attraverso il fondo SAFE (Security and Action For Europe), destinati direttamente alle principali industrie belliche europee.
In parole semplici: trattasi di un piano d’investimento da 800 miliardi di euro, atto a rafforzare gli eserciti nazionali europei aggirando le regole fiscali (senza intervenire dunque sull’introduzione di un debito comunitario). Il piano è qui inteso come un tentativo di omologazione degli impianti di difesa degli Stati membri, già parzialmente avviato dai requisiti dettati dalla NATO, ma ancora ben distante dal realizzare una piena interoperabilità tra gli armamenti dei Paesi dell’UE.
L’esigenza di tale programma sarebbe da attribuire alla minaccia di un progressivo disimpegno statunitense nella difesa degli altri membri dell’Alleanza Atlantica, con particolare riferimento agli Stati europei, voluto fortemente dal neo-rieletto presidente Donald J. Trump, che recrimina a questi ultimi di non rispettare gli standard minimi NATO di spesa militare al 2% in relazione al PIL, seppur con le dovute eccezioni (ad esempio la Polonia e i tre Paesi Baltici).
Un eventuale sfilamento statunitense dai vincoli imposti dal Patto Atlantico, con particolare riferimento al famigerato art. 5, che prescrive l’obbligo d’intervento di tutti i Paesi membri in caso di aggressione verso uno di questi, rappresenterebbe per l’UE una minaccia esistenziale concreta, in quanto si vedrebbe privata della deterrenza offerta dalle più di 3.700 testate nucleari a stelle e strisce.
D’altro canto, la propaganda “pro-riarmo” offre numerosi spunti in merito alla possibilità di imprimere un’ulteriore accelerazione al processo di integrazione europea in senso federalista, mediante l’omologazione degli arsenali nazionali.
Tuttavia, è legittimo domandarsi se un piano di riarmo dei singoli Stati europei sia effettivamente sufficiente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati di deterrenza e maggiore coesione, o se, al contrario, possa risultare in un ulteriore motivo di fratture, siano esse interne o di politica comunitaria. Anche i più ottimisti tra coloro che sono favorevoli al ReArm Europe convengono sul fatto che questo piano, sebbene svolto mediante progetti collaborativi tra le varie industrie nazionali, appaia del tutto insufficiente per raggiungere pienamente una capacità di dissuasione autonoma da eventuali attacchi esterni, tantomeno per dare un ulteriore slancio al processo di integrazione europea.
In primo luogo, risulta palese che la mancanza di uno Stato Maggiore comune infici in maniera determinante le capacità di coordinamento delle forze armate nazionali, che, sebbene riarmate, continuerebbero a rispondere unicamente ai propri Stati. In sostanza, gli interessi di questi non sono necessariamente convergenti con quelli comunitari, specialmente in un contesto nel quale le singole identità nazionali europee adottano scelte di politica estera spesso contrastanti fra loro.
Esempi lampanti di questa frammentazione sono, oltre all’approccio ostruzionista ungherese e sloveno nei confronti dei rifornimenti militari all’Ucraina, l’ambiguità italiana circa la sua aderenza a una politica più filo-statunitense che europeista (in un momento in cui, ora più che mai, queste due entità sembrano irrimediabilmente disallineate), in opposizione al blocco dei Paesi baltici, della Francia e della Germania, che mantengono una posizione fermamente anti-russa.
Ciò deriva da fattori strutturali che hanno accompagnato l’intero processo d’integrazione, sviluppatosi originariamente con l’obiettivo di offrire agli Stati membri un mercato comune, prima ancora di sviluppare una politica estera “europea”. Non mancarono eroici tentativi risalenti già al 1952, con la firma del patto istitutivo della CED (Comunità Europea di Difesa), naufragata, però, proprio a causa del fallimento della costituzione della CPE (Comunità Politica Europea).
Va da sé che un organo di coordinamento militare europeo non può che essere il frutto di un lungo processo politico, economico, sociale e culturale che comporta la cessione di sovranità da parte dei singoli Stati membri su temi quali la politica estera e la difesa. Ciò risulta, però, in totale controtendenza con il deciso avanzamento di movimenti e partiti euroscettici che si sta verificando in molti Stati europei, a partire dalla gestione della crisi economica del 2008.
L’Unione Europea è, per molti, sinonimo di austerità. L’introduzione di vincoli di bilancio nei singoli ordinamenti nazionali, finalizzata alla riduzione del debito pubblico, ha comportato pesanti tagli alla spesa pubblica, in particolare nel settore del welfare, e un generale aumento della disoccupazione.
Uno degli elementi che renderebbe il piano di riarmo europeo addirittura controproducente per il processo di integrazione risiede proprio in questo paradosso: per anni si sono giustificati tagli alla sanità, che hanno reso crisi come quella del Covid-19 particolarmente devastanti, e all’istruzione, invocando l’assenza di risorse, dovuta all’impossibilità di generare nuovo debito. Com’è possibile che ora si possa effettuare una spesa così ingente per il riarmo? Questo risentimento non può che accrescere ulteriormente le fila dei partiti sovranisti ed euroscettici, che vedranno, tra l’altro, i propri Stati riarmati, con esiti imprevedibili.
Usufruire della possibilità di sospendere il Fiscal Compact (versione rafforzata del Patto di Stabilità) potrebbe, conclusosi il piano di riarmo, rigettare i Paesi con i debiti pubblici più elevati in fasi austeritarie ancora più intense, con un conseguente aumento degli umori euroscettici: ben lungi, quindi, dal portare i sistemi nazionali e le rispettive opinioni pubbliche ad allinearsi in senso collaborativo.
Potrebbe essere utile, a questo punto, definire il concetto di “deterrenza”; questa può essere intesa come la cancellazione degli incentivi che spingerebbero un determinato soggetto a commettere un atto illegale o nocivo. Va da sé che la deterrenza si faccia contro un qualcuno di ben definito, che nel caso europeo, si tratterebbe della Federazione Russa.
Per essere efficace, la deterrenza deve fondarsi su tre elementi: la capacità (intesa come numerosità, potenza distruttiva e possibilità di penetrazione delle difese), la dimostrazione di avere intenzioni credibili, e, soprattutto, la percezione della volontà di utilizzare le armi nucleari, se costretti dagli eventi. Per quanto riguarda la capacità, la Russia ha un arsenale nucleare 12 volte più grande rispetto all’UE (6.375 della Russia contro 515 dell’UE).
In secondo luogo, le intenzioni credibili: come detto prima, l’UE non ha una politica unificata e chiara, al contrario del governo russo, estremamente centralizzato. Infine, riguardo la percezione della volontà di usare, se necessario, armi di distruzione di massa, la Russia ha una dottrina ben definita che contempla il ricorso a tali armi in caso di minacce esistenziali alla nazione. L’Unione Europea, al contrario, in una situazione di concreta minaccia nucleare, in assenza di una dottrina condivisa (e quindi, di una politica estera e di difesa comune) dovrebbe riunirsi e coordinare tutti i 27 Stati membri.
Perfino sul piano strategico ReArm Europe avrebbe risultati controproducenti: il cosiddetto “Paradosso della Sicurezza”, ampiamente discusso nella teoria delle relazioni internazionali, mostra come l’incremento degli armamenti, anche se motivato da ragioni di deterrenza, tenda ad alimentare l’insicurezza reciproca e la conseguente corsa agli armamenti, anziché placarla.
Appurato quindi che ReArm Europe non beneficerebbe né alla capacità di deterrenza comunitaria, né al processo d’integrazione politica degli Stati europei, rischiando addirittura di acuirne la frammentazione, è lecito domandarsi se le cause di questo piano non risiedano altrove.
Alcune premesse: l’industria europea, in particolare quella dell’automotive, è entrata in una profonda crisi a causa di molteplici fattori, fra i quali è possibile includere l’alta competitività dei prodotti cinesi e il tentativo di riconversione verso l’elettrico (a scapito della mobilità di massa), aggravata dalla successiva emergenza Covid e dall’imposizione dei dazi verso la Russia, che hanno aumentato drasticamente i costi dell’energia, in particolar modo per la Germania, paese trainante nel settore manifatturiero.
Osservando, ad esempio, gruppi come la Volkswagen (impresa di punta dell’industria automobilistica), si è assistito a un crollo delle vendite già a partire dal 2020, che ha implicato un piano di risparmio, annunciato nel dicembre 2024, che prevede, entro il 2030, il taglio di oltre 35.000 posti di lavoro. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, d’altronde, nel discorso che scandisce i primi cento giorni d’insediamento del suo secondo mandato, fa riferimento, a proposito del piano di riarmo, alle possibilità di rilancio dell’industria europea:
«È importante sottolineare che la forza economica e il piano europeo di riarmo sono due facce della stessa medaglia. Il potenziale economico e innovativo dell’Europa è una risorsa per la sua sicurezza, ma al contempo, gli sforzi europei per la difesa possono fornire una spinta enorme a un mercato unico più competitivo nel medio e lungo termine» (aise, 1/03/2025).
ReArm Europe, quindi, andrebbe contestualizzato all’interno di una complessa crisi industriale del Made in Europe di cui forse la nobile bandiera della “difesa comune” sta solo fungendo da paravento.
Il quesito finale, in sostanza, è di carattere squisitamente etico: può la riconversione dell’industria europea, in senso bellicista, essere considerata un valido antidoto alla grave crisi che attanaglia la produzione manifatturiera europea? Può questo piano beneficiare effettivamente alla condizione della popolazione del continente, o è da considerarsi, piuttosto, un palliativo atto ad aumentare momentaneamente gli introiti delle grandi industrie riconvertite alla difesa?
E soprattutto, è la strada del riarmo e della potenza l’unica percorribile dalla classe dirigente europea per portare a compimento l’edificazione della tanto necessaria Europa Unita? O ne esiste un’altra, decisamente più tortuosa, ma indubbiamente più appagante, fondata sulla giustizia sociale e sullo sviluppo di una vera sovranità democratica europea?
Andrea Passante – Viola Andreolli