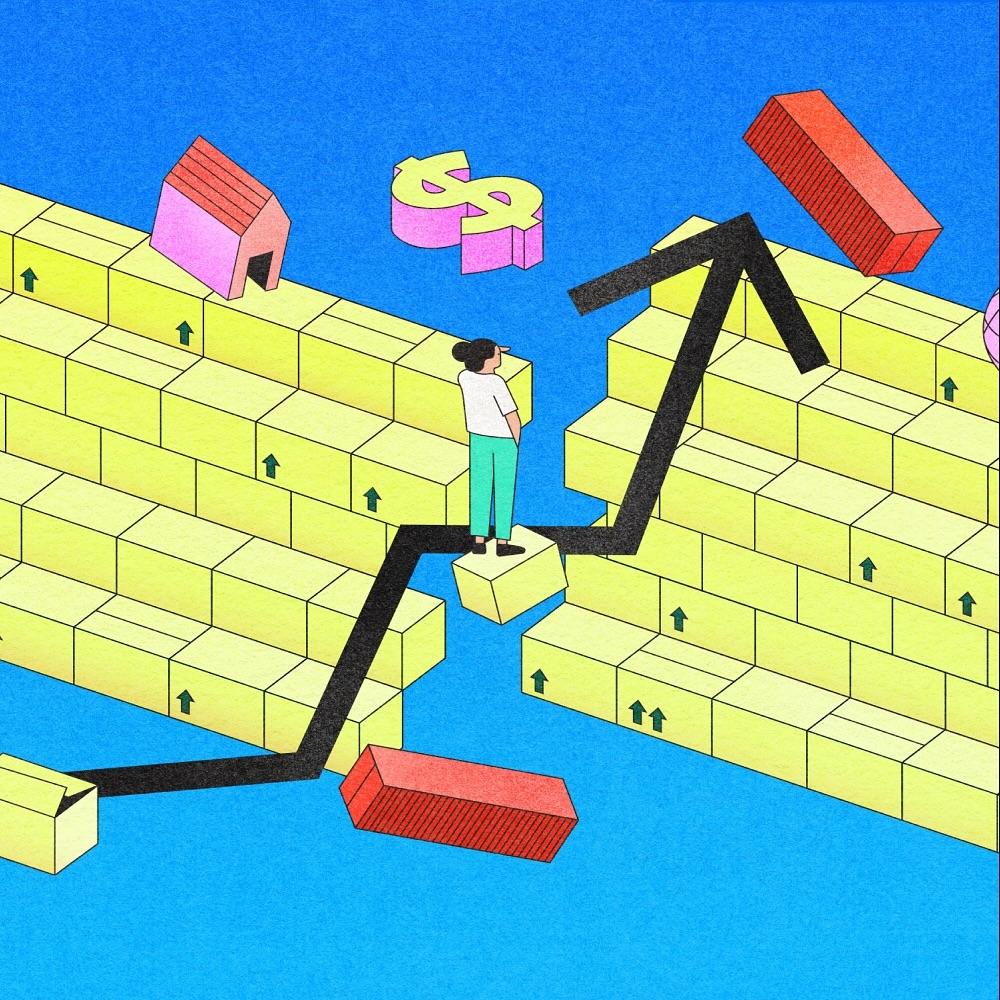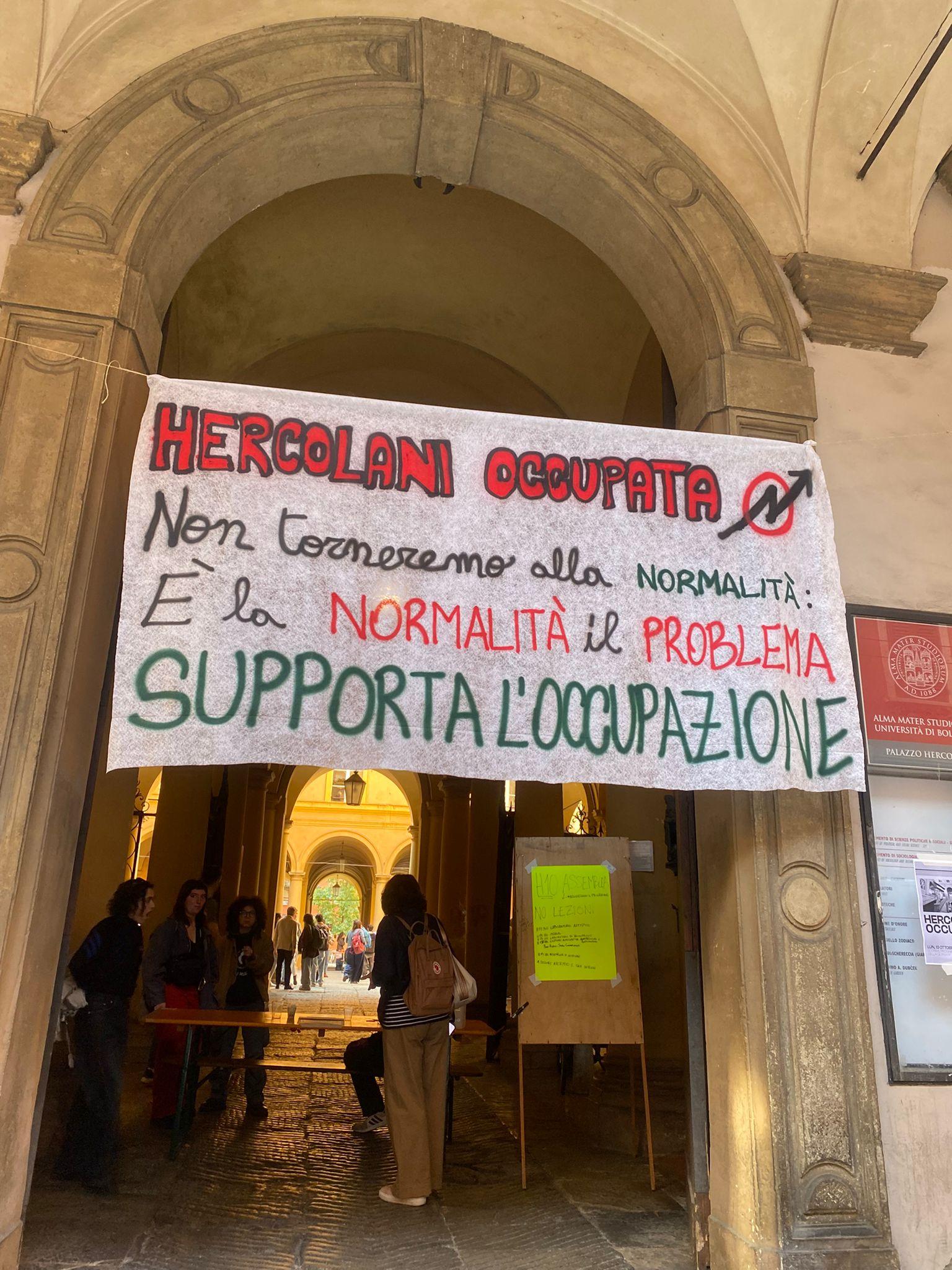29.04.2025 / Daria Casale – Manuele Baravelli
Negli ultimi anni, le tensioni commerciali tra Stati Uniti e altre potenze economiche sono tornate al centro del dibattito internazionale, in particolare a partire dalla presidenza di Donald Trump. Il suo approccio protezionista ha inaugurato una vera e propria “guerra dei dazi”, destinata a ridefinire gli equilibri del commercio globale.
Cosa sono i dazi e perché Trump ha iniziato la guerra commerciale
I dazi doganali sono imposte sui beni importati: servono ad aumentare i prezzi dei prodotti stranieri per proteggere quelli nazionali.
Trump, eletto con lo slogan America First, ha fatto dei dazi uno strumento politico ed economico centrale. La sua retorica puntava a colpire i Paesi che, secondo lui, approfittavano del libero mercato per “imbrogliare” gli Stati Uniti, ottenendo vantaggi commerciali ingiusti. Il bersaglio principale? La Cina.
La guerra dei dazi è cominciata formalmente nel 2018, con l’imposizione di tariffe su acciaio e alluminio da vari Paesi, inclusi alleati come Canada e Unione Europea. A seguire, è iniziata un’escalation con la Cina, che ha portato a dazi su centinaia di miliardi di dollari in merci.
Alla base di tutto c’era l’obiettivo di ridurre il deficit commerciale – che nel 2024 ha raggiunto i 98,4 miliardi di dollari (fonte: Trading Economics) – cioè la differenza tra quanto gli USA importano ed esportano, e riportare la produzione manifatturiera in patria, contrastando anni di delocalizzazione verso l’Asia.
Nel 2025, con un ritorno di Trump alla Casa Bianca, la linea dura è ripresa con nuovi dazi su quasi tutti i partner commerciali — compresi alleati storici come Corea del Sud, Giappone e persino Regno Unito e Australia.
Il concetto di “decoupling”
In questo contesto, si è iniziato a parlare di decoupling, ovvero il tentativo degli Stati Uniti di separare la propria economia da quella cinese.
Questo processo implica ridurre la dipendenza da Pechino, soprattutto in settori strategici come tecnologia, batterie e semiconduttori, e rilocalizzare la produzione o trasferirla in Paesi considerati più affidabili.
Non è solo una questione economica: il decoupling ha forti implicazioni geopolitiche, in un mondo sempre più diviso in blocchi.
Confusione e difficili risposte: il piano internazionale
Mentre Trump getta nel panico i mercati, gli attori internazionali guardano lo scontro tra Stati Uniti e Cina con preoccupazione. Tutti in attesa di pianificare possibili risposte e trattative per prendere nuova posizione nel terremotato commercio globale.
Cosa aspettarsi? Difficile prevederlo. Certo che lo tsunami che si è abbattuto sullo stato del commercio globale ha coinvolto tutti e che ci aspettano reazioni e contro misure continue nei prossimi mesi. Quel che è sicuro è che in pochi giorni Trump sia riuscito a portare 75 paesi alla Casa Bianca per contrattare -o a “baciare il culo”, a seconda dei punti di vista- e che soprattutto, in tanti si troveranno a dover diversificare i propri mercati.
Chi ha deciso di non piegarsi è sicuramente la Cina. Potenza maggiormente colpita e l’unica ad aver giocato qualche carta, sfidando il Tycoon a puntare al rialzo.
La Cina ha reagito con dazi di ritorsione su numerosi prodotti americani, colpendo in particolare i settori agricolo e automobilistico. Gli Stati Uniti hanno perso terreno in molti mercati, mentre altre potenze, come l’Unione Europea e il Giappone, hanno cercato di sfruttare il vuoto lasciato da Washington per rafforzare la propria posizione.
Sotto la presidenza Biden, il tono è cambiato, ma la sostanza è rimasta: molte delle tariffe di Trump sono ancora attive, e la logica protezionista non è stata abbandonata. Biden ha mantenuto un approccio cauto, cercando di proteggere le industrie americane ma evitando scontri diretti.
Nel 2024, il deficit commerciale degli Stati Uniti con la Cina era ancora altissimo — circa 295 miliardi di dollari. La Casa Bianca ha calcolato che la Cina imponeva “dazi virtuali” del 67% attraverso barriere non tariffarie e pratiche scorrette, giustificando così nuove imposte punitive.
Nel frattempo, anche altri Paesi hanno subito dazi: la Corea del Sud, pur avendo un accordo di libero scambio con gli USA, ha visto imposte del 26% sui suoi beni esportati. Persino gli alleati con cui gli Stati Uniti registrano un surplus commerciale, come Regno Unito e Australia, sono stati colpiti con tariffe del 10%.
La logica di risposta alla guerra innescata segue un pensiero semplice ma concitato: la Cina non ha alcuna volontà di portare avanti una guerra sui dazi, ma non ha nemmeno paura di combattere.
Direzione in piena armonia con la linea politica ed economica che Xi segue da quando è ai vertici del PCC. Allontanamento dalla dipendenza tecnologica verso Washington e rafforzamento del mercato interno, nonostante la produzione sia ancora troppo elevata rispetto ai consumi, costringendola a rendere l’export centrale.
Del resto, gli ultimi vent’anni hanno visto una già molte volte acclamata crescita economica per Pechino. Come dice il professore Xu Dingbo della CEIBS “L’influenza degli Stati Uniti sull’economia globale è molto inferiore a quanto molti di noi immaginano. La quota delle esportazioni statunitensi sul totale mondiale è scesa dal 15,51% nel 1970 al 9,8% nel 2023, mentre la quota della Cina è aumentata dallo 0,59% all’11,28% nello stesso periodo, e la Cina è il primo partner commerciale della stragrande maggioranza dei paesi del mondo. Le importazioni dalla Cina dagli Stati Uniti rappresentano solo il 6% delle importazioni totali della Cina, e le esportazioni dirette verso gli Stati Uniti rappresentano il 15% delle esportazioni totali. Gli Stati Uniti non sono più il primo mercato di esportazione della Cina, il primo mercato è l’ASEAN”
Lo scontro ha fatto lievitare le tariffe reciproche.
Se gli Stati Uniti dal 20% iniziale ora ne hanno imposto uno al 145% (e voci suggeriscono un ulteriore rialzo al 245), Pechino ha risposto con la scure. Dazi al 125%, restrizioni all’export di 12 prodotti legati alle terre rare, 17 imprese aggiunte alla lista di aziende inaffidabili -e quindi bloccate nell’ esportare e investire nel territorio cinese-, 28 aziende americane non riceveranno prodotti dual use cinesi. Xi ha posto il divieto di esportazione totale per 6 aziende Usa che vendono soia, sorgo e pollame. Sono partite alcune indagini contro Google e depositate diverse denunce all’Organizzazione Mondiale del Commercio contro i dazi americani, ritenuti illegali.
E se Trump si dice pronto a contrattare con il mondo, Xi ribatte anche qui, puntando ad aprire ulteriormente il mercato con Giappone e Corea del Sud, fino alla Malesia, dove ha incontrato i paesi ASEAN, cruciali per l’export globale e fortemente penalizzati da questa guerra.
Xi si propone come leader affidabile e unico reale interlocutore in grado di garantire accordi vantaggiosi per tutti, tanto da tendere la mano all’Europa -le parti si incontreranno a fine luglio-, chiamando alla formazione di un blocco compatto in opposizione a chi vuole alzare la marea dei dazi.
Effetti interni e internazionali
Questa strategia ha avuto effetti controversi:
-Aumento dei prezzi per i consumatori statunitensi.
-Difficoltà per le aziende che dipendono da fornitori stranieri.
-Perdita di competitività nei mercati esteri a causa delle ritorsioni.
L’industria automobilistica americana, in particolare, ha subito danni considerevoli. E mentre i dazi miravano a “rilanciare il Made in USA”, spesso hanno finito per danneggiare le stesse aziende che volevano proteggere.
Molti analisti ritengono che i dazi da soli non bastino a ridurre il deficit commerciale, che è legato anche a dinamiche più profonde come il basso risparmio interno e l’elevata spesa pubblica americana.
Europa: una risposta ancora da trovare ma qualcosa si muove
L’Europa vive nell’incertezza. Nonostante l’obiettivo americano sia quello di frammentare gli accordi con l’UE, proponendo contrattazioni bilaterali, Bruxelles ha manifestato una flebile volontà di mantenere il fronte unito nel cercare altri lidi nei quali investire.
Non analizzeremo i vari paesi, allineati su diversi piani di risposta. Ma è interessante come al momento la Commissione Europea stia cercando di spostare almeno un occhio su altri mercati. Con i paesi dell’Asia centrale ed il Sud Africa, nei quali nell’ultimo mese sono stati firmati una serie di importanti accordi e che, si spera, siano un primo passo per un maggiore coinvolgimento europeo nel mercato globale.
Nei confronti dell’Asia centrale, l’Unione sta provando ad inserirsi in un contesto, fin ora, estraneo alle attenzioni mediatiche occidentali. In un’area di tradizione ex sovietica e che ha spinto negli ultimi anni investimenti cinesi. I paesi della regione stanno provando a seguire un progetto di integrazione per trovare compattezza e crescita comune.
L’UE dal canto suo punta a rendersi autonoma per quanto riguarda il commercio di materie prime critiche. Ci prova investendo 10 miliardi di euro tramite il progetto “Global Gateway Strategy” e comprendendo un accordo per la costruzione di sistemi di trasporto commerciale tra le due regioni, promettendo ulteriori incontri di sviluppo delle relazioni con i paesi “stan”
Le relazioni con il Sud Africa erano invece più ricorrenti e partivano da basi già costruite ma che hanno trovato una nuova possibilità di allargamento. La commissione ha deciso di investire 4,7 miliardi di euro per sostenere tre progetti: dalla produzione di vaccini e farmaci in Sud Africa, il supporto ad una transizione energetica giusta, che parta dall’estrazione di materie prime critiche e la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio, infrastrutture di connettività, compresi i trasporti (sviluppo del corridoio strategico Nord-sud) e digitale.
Sicuramente il percorso per avere un’unione più indipendente dagli scossoni trumpiani è ancora lungo e tortuoso, specialmente sarà difficile prevedere gli accordi che Von Der Leyen e Trump troveranno. Ma la strada potrebbe essere valida, staremo a vedere.
L’Italia è invece stata la prima a muoversi verso una posizione maggiormente conciliatoria rispetto ai casi analizzati. Anche perché è quella con minor peso di contrattazione. Meloni lo sapeva, o quantomeno se n’è dovuta accorgere. Si è comunque presentata nello studio ovale il 17 aprile senza realisticamente poter ottenere nulla di concreto. La contrattazione commerciale è prerogativa della Commissione Europea e dunque, l’unico scopo che aveva era quello di sondare l’elasticità americana chiedendo di attuare una soluzione di liberalizzazione totale dei mercati, azzerando i dazi.
Il Tycoon ha naturalmente risposto picche ma ha ancora una volta riempito di elogi la premier.
Nonostante l’Europa dica che è possibile sfruttare lo stretto rapporto tra i due, fin ora non sembrano arrivare i risultati che FdI si augurava.
Sarà arrivato finalmente il momento di rendersi conto che gli americani stanno provocando grossi danni all’Italia e all’Europa? Probabilmente si, anche se, in uno scenario così incerto sarà importante lavorare su più fronti, cercando di sfruttare ogni possibilità che ci si troverà di fronte nei prossimi tre anni e mezzo, con l’impegno di emanciparsi il più possibile senza cadere nel baratro di un suicidio economico e politico sempre all’orizzonte.
Uno sguardo al futuro: cosa ci lascia questa guerra commerciale
La guerra dei dazi ha messo in luce un cambiamento profondo: il libero scambio globale, così come l’abbiamo conosciuto, non è più garantito. Non è solo una questione di Trump o Biden, si tratta di una trasformazione più ampia, in cui le grandi potenze, a cominciare da Stati Uniti e Cina, usano il commercio come leva geopolitica, un’arma strategica per rafforzare la propria influenza.
I dazi, nella pratica, spezzano l’idea di un mercato globale integrato. E colpiscono soprattutto merci prodotte nell’Est di cui l’Ovest ha ormai bisogno per mandare avanti il proprio sistema economico: componenti elettronici, macchinari, beni di consumo. È una mossa che tocca il cuore stesso delle catene globali di produzione. Ma può portare anche qualcosa di buono? Forse sì. Non per tutti, certo, ma ci sono vincitori e vinti. Alcuni settori locali possono trarre vantaggio da una protezione temporanea, le imprese che avevano delocalizzato potrebbero riportare parte della produzione in patria. In effetti, si stanno già vedendo segnali concreti di reshoring e di diversificazione delle catene di fornitura. La Cina non è più l’unico hub mondiale.
Il mondo intanto cambia. L’Europa si muove con cautela, ancora strettamente intrecciata agli Stati Uniti e non sempre pronta a rispondere con prontezza alle sfide internazionali. La Cina, nel frattempo, punta sulla domanda interna e sul rafforzamento dei legami con il Sud-est asiatico. L’Italia potrebbe ritagliarsi un ruolo rilevante, ma solo attraverso scelte strategiche: investire in innovazione, diversificare i mercati e restare connessi alle reti globali in modo intelligente. Per ora, sembra intenzionata a mantenere saldi i rapporti con Washington -lo testimoniano gli incontri alla Casa Bianca e le parole del vicepresidente Vance, che su Instagram ha definito l’Italia “una grande alleata degli Stati Uniti” e ha raccontato come “un onore” l’incontro con il Papa e la premier Meloni durante la visita romana nella Settimana Santa.
Il protezionismo è tornato. Ma il mondo non può -e forse non deve- chiudersi del tutto. La sfida sarà gestire questa nuova fase con realismo: non solo barriere, ma anche alleanze selettive, produzione strategica e diplomazia economica. Il commercio del futuro sarà più frammentato, sì, ma anche più consapevole.
In questo contesto, alcune voci critiche si alzano anche dall’interno dell’Europa. Tra queste, quella dell’economista ed ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis, che ha criticato duramente la risposta europea all’escalation americana.
“Trump non è pazzo, è razionale. Sono i leader europei a comportarsi da matti”, ha dichiarato Varoufakis in un’intervista rilasciata a Londra. Secondo lui, la strategia di Trump ricorda quella di Nixon nel 1971, quando azioni shock sul dollaro rivoluzionarono gli equilibri economici globali.
Il cuore della strategia americana non sarebbero tanto i dazi in sé, quanto il deprezzamento del dollaro, usato come leva per aumentare la competitività dell’export USA. I dazi, sostiene, sono solo uno strumento tattico e reversibile. Il vero obiettivo è rilanciare l’economia statunitense spostando l’asse commerciale globale.
Varoufakis denuncia il vuoto strategico dell’Europa, incapace di elaborare una risposta credibile:
“Abbiamo un saldo netto positivo di 240 miliardi verso gli Stati Uniti, come possiamo pensare di vincere una guerra dei dazi?”
Secondo lui, l’Europa dovrebbe coordinarsi con la Cina, smettere di applicare dazi contro prodotti utili come pannelli solari o auto elettriche, e avviare un grande piano di investimenti pubblici. In caso contrario, l’unica prospettiva sarà una lunga stagnazione.
“Tutto quello che esce da Bruxelles è stupidità organizzata. Continuano a parlare di dazi, di bloccare le esportazioni cinesi verso l’Europa, e comunque — diciamoci la verità — da vent’anni a questa parte, per via di politiche assurde di austerità per i molti e di privilegi per i pochissimi, non abbiamo più fatto investimenti in Europa.
È per questo che ci siamo persi la rivoluzione tecnologica. Abbiamo avuto la crisi dell’euro, la pandemia: erano occasioni perfette per consolidare, per rilanciare un piano di investimenti aggregati. Ma non è stato fatto. Qualcuno ne sta parlando? No.
Si parla solo di spostare soldi dal settore sociale a Rheinmetall per produrre carri armati che né ci servono né vogliamo. Alla fine, sta a noi reagire in modo positivo a Trump. Ma io non vedo segnali di intelligenza da Bruxelles su questo fronte”.
Per Varoufakis, dunque, il problema non è Trump, ma l’incapacità dell’Europa di uscire dal suo modello mercantilista e reinventarsi. Le sue parole non sono un endorsement alla strategia americana, ma un forte richiamo alla realtà per un’Europa che rischia di trovarsi senza margine di manovra -e senza visione.
Daria Casale – Manuele Baravelli